Alle ore 22.39 del 9 ottobre 1963, circa 260 milioni m³ di roccia[1][2] (un volume più che doppio rispetto a quello dell'acqua contenuta nell'invaso) scivolarono, alla velocità di 30 m/s (108 km/h), nel bacino artificiale sottostante (che conteneva circa 115 milioni di m³ d'acqua al momento del disastro) creato dalla diga del Vajont, provocando un'onda di piena tricuspide che superò di 250 m in altezza il coronamento della diga e che in parte risalì il versante opposto distruggendo tutti gli abitati lungo le sponde del lago nel comune di Erto e Casso, in parte (circa 25-30 milioni di m³) scavalcò il manufatto (che rimase sostanzialmente intatto, pur avendo subito forze 20 volte superiori a quelle per cui era stato progettato, seppur privato della strada carrozzabile posta nella parte sommitale) e si riversò nella valle del Piave, distruggendo quasi completamente il paese di Longarone e i comuni limitrofi, e in parte ricadde sulla frana stessa (creando un laghetto).[2] Vi furono 1917[3] vittime di cui[4] 1 450 a Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e 200 originarie di altri comuni.
Lungo le sponde del lago del Vajont vennero distrutti i borghi di Frasègn, Le Spesse, Il Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana, San Martino, e la parte bassa dell'abitato di Erto[6]. Nella valle del Piave vennero rasi al suolo i paesi di Longarone, Pirago, Faè, Villanova, Rivalta, e risultarono profondamente danneggiati gli abitati di Codissago, Castellavazzo, Fortogna, Dogna e Provagna. Vi furono danni anche nei comuni di Soverzene, Ponte nelle Alpi, nella città di Belluno a Borgo Piave, e nel comune di Quero Vas, nella borgata di Caorera dove il Piave, ingrossato dall'onda allagò il paese e raggiunse il presbiterio della chiesa.
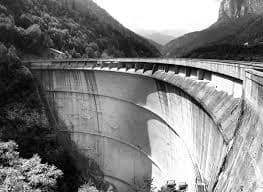
L'evento fu dovuto a una serie di cause, di cui l'ultima in ordine cronologico fu l'innalzamento delle acque del lago artificiale oltre la quota di sicurezza di 700 metri voluto dall'ente gestore, operazione effettuata ufficialmente per il collaudo dell'impianto, ma con il plausibile fine di compiere la caduta della frana nell'invaso in maniera controllata, in modo che non costituisse più pericolo. Questo, combinato a una situazione di abbondanti precipitazioni meteorologiche e a forti negligenze nella gestione dei possibili pericoli dovuti al particolare assetto idrogeologico del versante del monte Toc, accelerò il movimento della antica frana presente sul versante settentrionale del monte Toc, situato sul confine tra le province di Belluno (Veneto) e Pordenone (Friuli-Venezia Giulia). I modelli usati per prevedere le modalità dell'evento si rivelarono comunque errati, in quanto si basarono su una velocità di scivolamento della frana nell'invaso fortemente sottostimata, pari a un terzo di quella effettiva.
Nel febbraio 2008, durante l'Anno internazionale del pianeta Terra (International Year of Planet Earth) dichiarato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una sessione dedicata all'importanza della corretta comprensione delle Scienze della Terra il disastro del Vajont è stato citato, assieme ad altri quattro eventi, come un caso esemplare di "disastro evitabile" causato dal «fallimento di ingegneri e geologi nel comprendere la natura del problema che stavano cercando di affrontare».

PRODROMI DEL PROGETTO
La strutturale carenza italiana di materie prime come il carbone per il proprio fabbisogno energetico aveva portato il paese a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, specializzandosi in una politica energetica che si può definire antesignana delle 'energie rinnovabili', che portò allo sfruttamento di valli e corsi d'acqua montani, dove vennero realizzate numerose centrali idroelettriche che avrebbero prodotto la maggior parte dell'energia elettrica nell'Italia del Nord, fondamentale per lo sviluppo industriale del Paese. Questa politica, che non considerava appieno le interazioni uomo-ambiente e le necessità di rispetto dell'ambiente, risultava essere una soluzione quasi obbligata.
L'idea di sfruttare come bacino idroelettrico la valle del fiume Vajont tramite una diga venne concretizzata dalla Società Idroelettrica Veneta, poi assorbita dalla SADE (Società Adriatica Di Elettricità), particolarmente attiva alla fine del XIX e nella prima metà del XX secolo nella produzione e distribuzione elettrica nel nord-est italiano[8] (prima della nazionalizzazione del settore elettrico dell'intera Italia attuata attraverso la nascita di un "Ente Nazionale per l'Energia Elettrica", l'ENEL).
In questo contesto, la prima ipotesi di un progetto di massima per lo sfruttamento delle acque del torrente Vajont venne redatta dall'ingegner Carlo Semenza nel 1926. La diga era prevista alla stretta del ponte di Casso (un tempo esistente a est dell'attuale zona artigianale ai piedi del bivio per Casso) e prevedeva una centrale a Dogna. La scelta era figlia di una raccomandazione del Prof. Hug, che aveva sconsigliato l'alternativa più a valle, all'altezza del ponte del Colomber (dove il manufatto venne in seguito effettivamente costruito).

Nel 1929 venne presentata la domanda di concessione per la realizzazione di un progetto di diga al ponte di Casso (massimo invaso a quota 656 m s.l.m.) con allegata la relazione di Hug del 1926. Gli studi geologici sulla valle interessata dal nuovo invaso proseguirono e nel 1930 il geologo Giorgio Dal Piaz presentò una relazione inerente all'assenza di franamenti importanti lungo le sponde del bacino tra la zona di Pineda (a est) e il ponte di Casso (a ovest).
Nel 1937 venne presentato un nuovo progetto, con spostamento della diga più a ovest presso il ponte del Colomber all'altezza del punto in cui la strada che da Longarone saliva a Erto valicava la forra sul torrente Vajont passando dalla sponda sinistra a quella destra della valle. Il massimo invaso era previsto a quota 660 m s.l.m.; a esso era allegata una relazione geologica a firma di Dal Piaz, sostanzialmente combaciante con quella del 1930, che estendeva la validità delle sue affermazioni fino alla nuova posizione della diga. Va sottolineato tuttavia che in una sua precedente relazione del 1928 Dal Piaz si era sempre opposto alla sbarramento della valle presso il ponte di Casso, in quanto riteneva la roccia di imposta della diga in quel punto poco adatta, per cui il manufatto non avrebbe potuto essere più alto di cinquanta metri dalla base del torrente.